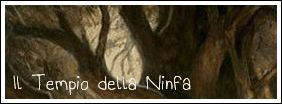
Le Streghe dello Sciliar Articoli / Racconti Inviato da Violet 03 Apr 2020 - 18:42 |
|
LE STREGHE DELLO SCILIAR Leggenda dolomitica dell’Altopiano dello Sciliar Sull’Alpe di Siusi, ai piedi del massiccio dello Sciliar in Alto Adige, esiste una leggenda che narra della metamorfosi di alcune donne selvatiche in fiori, e della loro successiva rinascita nel mondo in forma di bellissime fanciulle. La storia si inserisce nel contesto della saga altoatesina di Re Laurino e del Rosengarten, il mitico Giardino delle Rose del Catinaccio, ed è raccontata come segue. Quando la cicogna è proprio di buon umore e vuole portare in città una bella bambina – non una bimba comune, una veramente bella – con gli occhi che sono scuri senza però essere neri e di cui difficilmente si riesce a stabilire il colore e coi capelli biondo scuro, né biondi né neri, ma per l’appunto di quel colore biondo scuro tipico di Bolzano, non la prende nei soliti luoghi. Non vola infatti verso le pozzanghere del Talvera vicino alla cascata di Gries e nemmeno verso Longiarù, dove l’Isarco indolente e lento si snoda in un ramo laterale, vola invece al santuario del Kalvarienberg sul Catinaccio. Quassù vicino alla scala di pietra, che porta alla chiesetta, proprio sulla strada, si trova una cappella. Dentro vi è una fontana con due bacini, ed è proprio da quello sinistro – perché nel bacino destro nuotano i ragazzi – che la cicogna prende, fin dai tempi più antichi, le più belle bimbette e le porta giù in città. A parte la madre e il padre nessuno sa ancora della bellezza di questa bimba e della sua provenienza dal Kalvarienberg. Ma non passerà molto tempo e tutta la città se ne accorgerà, tutti quelli che avranno occhi per vedere l’ammireranno e molti non comprenderanno come un essere umano possa essere così bello. E proprio a questi dubbiosi voglio narrare la mia storia, tanto gli altri non la capiscono. Moltissimi anni sono trascorsi da quando il Catinaccio era ancora un giardino pieno di rose in fiore e il piccolo re Laurino portava la corona. A quel tempo fiorivano sulla Sciliar rosmarino, gigli e garofani. Molto spesso però il piccolo re guardava pieno di invidia e di astio, dalle sue guglie rocciose, questi fiori meravigliosi, mentre qualche gigante balordo, qualche nano brontolone e non ultimi i ragazzi di Siusi e di Fiè corteggiavano le salighe, che avevano il compito di curare i fiori del giardino dello Sciliar. Giganti e nani, ragazzi di Siusi e di Fiè sospiravano e si lamentavano allora, come fanno oggi i ragazzi di Bolzano. Quando le rose di re Laurino furono calpestate e lui fu trasportato prigioniero a valle, una delle salighe, scesa proprio quel giorno a Tires con un mazzo di garofani per una sua vecchia parente, che era ammalata, derise il povero re. Laurino su sconvolto dalla rabbia e maledisse il giardino dello Sciliar, trasformando le belle giardiniere in orribili streghe. Allora lo Sciliar divenne selvaggio come lo è oggi e così nacquero quei fiori blu, che dopo la fioritura sembrano avere dei capelli arruffati – le streghe dello Sciliar appunto. E le cose avrebbero dovuto rimanere così fino alla fine dei tempi, perché non c’era nessun sacerdote in grado di spezzare l’incantesimo. Nessuno infatti sapeva che i fiori blu fossero salighe maledette, e così nessuno si è mai preoccupato delle streghe dello Sciliar. In genere succedeva solo che qualcuno, venuto sullo Sciliar a dire messa nella cappella di San Cassiano, ne calpestasse qualcuna. Ma questo non è certo servito a liberarle dall’incantesimo. Per fortuna però si mise al lavoro il vento dello Sciliar, un forzuto gigante con la barba, non esattamente gentile ma certo di buon cuore. Un bell’autunno cominciò a ululare e soffiare, tanto che i poveri fiori dello Sciliar ne furono estremamente impauriti. Ma quanto più questi tremavano per la paura, tanto più quello soffiava tempestoso. Le streghe dello Sciliar non riuscivano quasi più a stare attaccate a terra, per la violenza con cui questo soffiava selvaggiamente strappando ad una i capelli, all’altra tutta la testa – whum, wuh, wuh, su in cima fino alle nuvole e poi veloce giù fino a valle. Dopo aver giocato a sufficienza con i capelli delle streghe, il vento le gettò, senza starci a pensare, vicino alla cappella del Santo Sepolcro al santuario del Kalvarienberg. In autunno poi la vecchia sacrestana, che va sempre su a levare le erbacce intorno alla chiesa sul piazzale sassoso, raccolse anche qualche strega dello Sciliar, che a sera buttò insieme a tutte le altre erbacce nella fontana della cappella. Il giorno seguente la Nandl [la sacrestana] si meravigliò di trovare ancora tanta erbaccia e sicuramente si chiese da dove venisse. Non si diede però troppi pensieri, perché le importava solo di toglierla di mezzo. Sapete però che cosa è successo con le streghe dello Sciliar nella cappella? Sono state tutte trasformate in tante piccole salighe. In quel luogo sacro la maledizione di Laurino si era spezzata. E quando la cicogna è proprio di buonumore e vuole portare in città una bimba veramente bella, allora non vola né verso le pozzanghere del Talvera né verso Longiarù, vola invece al santuario di Kalvarienberg e prende una delle salighe, che tanti, tanti anni orsono curavano i fiori sullo Sciliar e che poi – e questo non si deve dimenticare – furono trasformate con un incantesimo in streghe. (1) *** Il misterioso fiore dello Sciliar Determinare con sicurezza il fiore di cui narra la leggenda non è semplice, poiché il suo nome corrisponde ad una specie, mentre la descrizione che ne viene fatta appartiene a un’altra. Il fiore montano che in lingua tedesca è detto Schlernhex – plurale Schlernhexen – ovvero strega dello Sciliar, è lo Spillone, o Spillo, di dama, chiamato anche Spillone alpino e Statice montana. Il suo nome botanico è Armeria alpina, cresce fra le rocce, sui prati montani e i ghiaioni, ed è caratterizzato da uno stelo eretto, lungo e sottile, e da un’infiorescenza sferica formata da tanti capolini rosa intenso, talvolta tendenti al lilla. Fiorisce durante l’estate, da luglio a fine agosto, ed è molto diffuso sullo Sciliar, tanto da esserne diventato il simbolo. (2) La piantina descritta nella leggenda, però appare completamente diversa, e corrisponde in realtà alla specie delle Pulsatille, in particolare alla Pulsatilla montana, chiamata comunemente Anemone montana. Il suo stelo è corto e piuttosto spesso, e i suoi fiori lievemente penduli sono di un colore blu, ceruleo o violetto intenso, oppure rosso porpora. La pianta è interamente ricoperta da una fitta peluria bianco argentea, e al termine della fioritura, che avviene in primavera, il fiore lascia il posto a un’infruttescenza formata da lunghi e sottili filamenti che somigliano a ciuffi di capelli arruffati. Per questa sua particolare caratteristica la Pulsatilla è stata sovente associata alle streghe, e in alcune zone della Svizzera è chiamata c’avì t la strìa, ovvero “capelli della strega”, o c’avì du diauru, “capelli del diavolo”. (3) La sua etimologia è interessante, anche in relazione alla leggenda dolomitica. La parola latina botanica pulsatilla è una derivazione di pulsatus, participio passato di pulsare, col senso di “fremere, vibrare, sussultare, agitare”, ad indicare il muoversi costante degli acheni filamentosi, che tremano al minimo soffio d’aria. Anche la sua denominazione volgare ha un significato relativamente simile: il termine anemone proviene dal greco anemos, ovvero “vento”, e la piantina è così detta perché “cresce in luoghi aperti, ventosi, o perché si apre ai primi venti della bella stagione, o perché ha un lungo stelo, che la brezza più leggera agita e facilmente abbatte.” (4) Nella leggenda è proprio il “forzuto” vento montano che, prendendo a soffiare e ad agitare le piccole streghe dello Sciliar, le strappa e le getta infine nei pressi della sorgente sacra, creando al contempo le condizioni adatte alla loro rinascita in forma di fanciulle. Appare dunque evidente il forte legame che esiste fra questi delicati fiori e il vento, e per estensione, fra i venti selvaggi che soffiano sulle Alpi e le belle streghe, che da essi animate, fremono ed eternamente danzano sui pianori delle montagne. *** Lo Spillo di Dama o Schlernhex (Strega dello Sciliar) Armeria alpina   L’Anemone montana Pulsatilla montana   L’Anemone montana dopo la fioritura Fotografia di Tom Dempsey  Il Massiccio dello Sciliar Veduta dall'Alpe di Siusi  *** Note: 1. La leggenda è interamente tratta da Ulrike Kindl, Le Dolomiti nella Leggenda, Editrice Frasnelli Keitsch, Bolzano, 1993, pagg. 147-149. 2. Cfr. Claudio Cima, Sui Sentieri delle Leggende, pag. 44. 3. Cfr. Dizionario Leventinese [1] 4. Cfr. la voce Anemone [2] in Ottorino Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana Bibliografia Cima Claudio, Sui Sentieri delle Leggende. Itinerari scelti nei luoghi delle leggende dolomitiche, Edizioni Mediterranee, Roma, 1992 Kindl Ulrike, Le Dolomiti nella Leggenda, Editrice Frasnelli Keitsch, Bolzano, 1993 Pianigiani Ottorino, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Albrighi & Segati, Milano, 1907 Actaplantarum [3] Dizionario Leventinese [4] Etimo [5] Ricerca e nota a cura di Laura Violet Rimola. Nessuna parte di questo testo può essere riprodotta o utilizzata in alcun modo e con alcun mezzo senza il permesso scritto dell'autrice e senza citare la fonte. |
|
Questo articolo è stato inviato da Il Tempio della Ninfa http://www.tempiodellaninfa.net/public/ La URL di questo articolo è: http://www.tempiodellaninfa.net/public/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=341 Links in questo articolo [1] http://www.tempiodellaninfa.net/public/https://sites.google.com/site/leventinese/piante [2] http://www.etimo.it/?cmd=id&id=925&md=7b81cb92ac10ad0449dd5934134278ca [3] http://www.tempiodellaninfa.net/public/https://www.actaplantarum.org [4] http://www.tempiodellaninfa.net/public/ https://sites.google.com/site/leventinese/piante [5] http://www.etimo.it |